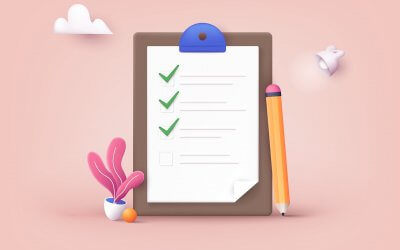Il 23 ottobre di 100 anni fa nasceva Gianni Rodari, una vita spesa a inventare storie fantastiche e a immaginare la scuola per i cittadini del domani. Rodari, da geniale pedagogo qual era, voleva insegnare “l’arte di inventare storie”. Così cita il sottotitolo del suo volume La grammatica della fantasia, un testo fondamentale per gli educatori e tanto più per la scuola di oggi, che si trova nel suo momento più difficile e deve imparare a usare la didattica a distanza per conquistare l’attenzione dei ragazzi. Certo, non tutti erano Rodari, ma lui stesso teorizzava la fantasia e il suo scopo era trasmettere agli insegnanti le tecniche per usarla.
“Chiedo scusa alla favola antica se non mi piace l’avara formica. Io sto dalla parte della cicala che il più bel canto non vende, regala.”
Ma la grande lezione di Rodari è un lascito contenuto nella sua Grammatica della fantasia, la risposta all’interrogativo più importante: a cosa servono le fiabe? Le fiabe servono all’uomo completo. Se una società basata sul mito della produttività (e sulla realtà del prodotto) ha bisogno di uomini a metà – fedeli esecutori, diligenti riproduttori, docili strumenti senza volontà – vuol dire che è fatta male e bisogna cambiarla. Per cambiarla occorrono uomini creativi, che “sappiano usare la loro immaginazione”, scriveva Rodari nel suo volume La grammatica della fantasia. Ma in un mondo fatto di algoritmi e reti informatiche c’è ancora posto per le fiabe? Oggi, che i cacciatori di teste cominciano a cercare ingegneri-filosofi, forse torna d’attualità quanto scriveva Rodari: “Le fiabe servono alla matematica come la matematica serve alle fiabe. Servono alla poesia, alla musica, all’utopia, all’impegno politico: insomma all’uomo intero, e non solo al fantasticatore. Servono proprio perché, in apparenza, non servono a niente: come la poesia e la musica”. L’immaginazione: una chiave per capire il mondo. Secondo Rodari, le favole erano un tassello formativo importante nell’educazione dei bambini. E non solo. Perché poi le sue storie si rivolgevano anche agli adulti e a quel bimbo sepolto dentro di loro, che aveva ormai perso la capacità di usare l’immaginazione. Fiabe come quella di Giovannino Perdigiorno, che finisce nel paese degli uomini con “il motore al posto del cuore”. O come quella del barbiere di Leonardo da Vinci, che ispirato dall’estro del suo cliente, aveva iniziato a collezionare i ciuffi di barba dell’artista e poi di tanti altri. Secoli dopo un suo discendente, che aveva ereditato la bottega di barbiere, ormai in crisi perché le barbe non andavano più di moda, ebbe l’idea di fare una nuova barba con i tanti ciuffi sparsi. E quella strana cosa dai mille colori si moltiplicò e distribuì i suoi ciuffi al mondo: “Le nuove barbe iniziarono a crescere e gli uomini che la portavano ricominciarono ad esprimere le loro capacità artistiche, a creare qualcosa di nuovo, qualcosa di bello e a migliorare il mondo che li circondava. La gente ritornò a respirare, a vivere, a pensare e ad essere felice”. Non è forse quanto è successo negli ultimi anni? Le lunghe e fantasiose barbe sono tornate di moda grazie alla generazione hipster, che si rifà alla cultura alternativa degli anni ’40 e all’età del jazz. Quando tutto era ancora da inventare, avrebbe detto Rodari. Crea immagini, incita all’azione, è un giocoliere colorato che ha la capacità di esprimersi in modo semplice e far arrivare a tutti un pensiero che è vitale e può cambiare il modo di pensare. Nei suoi giochi di parole e in alcuni dei suoi lavori si denota una ricerca scientifica sulle persone e sul quotidiano che descrive nei sui racconti con espressioni semplici per far comprendere la lettura a tutti. Non ci sono limiti alla fantasia, non bisogna mai avere paura della parola fine. Gianni Rodari lo sapeva e per questo durante tutta la sua vita — da partigiano, giornalista, intellettuale, pedagogista e scrittore — non smise mai di interrogarsi e immaginare. A noi non resta che leggerlo e sorprenderci insieme ai bambini, «non per diventare letterati o poeti, ma — come ripeteva Rodari — perché nessuno sia più schiavo».
Gaia Lupattelli